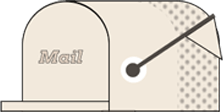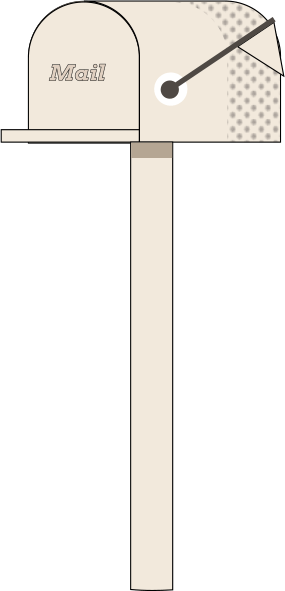Dan Peterson è uno di quei nomi che grazie a competenza nel suo lavoro, vittorie e carisma è riuscito a superare i limiti dati da ruolo e sport, diventando un’icona anche oltre la durata della carriera. Ma la sua importanza nell’ambito di riferimento, che per chi non lo sapesse sarebbe la pallacanestro, ha fatto anche di più, trasformando quello che era il basket italiano dei suoi tempi.
“Nato nel 1936 a Evanston, in Illinois, intraprende la carriera da allenatore praticamente da subito, come fosse una vocazione”.
Durante gli studi infatti Peterson era un giocatore di basket ed è il suo coach Jack Burmaster a notare che ha talento non sul campo, ma sulla panchina. Gli indizi c’erano: nella YMCA della città guidando la Ridgway Club aveva vinto tre titoli in tre anni. Così nel 1962 comincia la sua carriera ufficiale come assistente.
Le ossa se le fa nel sistema universitario americano, tra Michigan State, che parecchi anni dopo sarà nota a tutti grazie a un certo Magic Johnson, USNA e Delaware. Qui diventa head coach a 30 anni, nel 1966, e in cinque stagioni a somma 69 vittorie e 49 sconfitte.

La carriera del coach più amato dagli italiani, o quantomeno da quelli che tifano Olimpia, era però destinata a seguire un percorso diverso. Nel 1971 lascia la sua terra d’origine per andare ad allenare la selezione del Cile.
La nazionale sudamericana voleva fortemente una figura giovane, americana e con esperienza per far crescere il proprio movimento.
Anche oggi, infatti, se non avete mai sentito parlare del Cile in ambito cestistico un motivo c’è. Dopo un certo corteggiamento comunque Peterson accetta, pur non sapendo nulla del basket fuori dai confini degli Stati Uniti.
“Tutto quello che sapevo del basket FIBA era che partecipavano ai giochi olimpici ogni quattro anni e che il mondo stava a un livello molto più basso rispetto agli USA”.
Il progetto affidato a Peterson è di ampio respiro. Non solo plasmare una squadra, ma far conoscere la nazionale a ogni livello: il coach è una specie di ambasciatore con vari compiti, come osservare giocatori, valutarli, reclutarli, parlare con gli allenatori, farsi conoscere in ogni città.
Il Cile gioca 15 amichevoli fuori da Santiago arrivando anche negli Stati Uniti e Dan è il suo volto ufficiale. Il viaggio cambia il livello della squadra, trasforma il gruppo da un insieme di elementi di terzo livello in uno di primo.
Più forti e consapevoli. I primi semi del viaggio da allenatore e gestore di grandi gruppi sono qua.
“Il lavoro in Cile fu il motivo del mio successo in Italia. Per prima cosa portai lo stesso tipo di allenamento a Bologna e a Milano. Soprattutto l’esperienza mi cambiò a livello di sensibilità: imparai molto sulla gente, sulla cultura e sul basket fuori dagli USA”.
Il suo lavoro col Cile termina nel 1973, quando viene a lavorare in Italia, alla Virtus Bologna. Anche qui nella scelta il coach è orientato solo dalla sua voglia di nuove esperienze:
“Mi telefonò un avvocato, mi disse che un club di Bologna cercava un coach. Feci un salto qui e poi mi interessava maturare altre esperienze, conoscere il basket europeo, quello italiano, conoscere l’Italia, il vostro modo di vivere”.
Per sua stessa ammissione non sa nulla di basket italiano, ma impara in fretta. Porta il suo bagaglio di esperienze, attenzione su fondamentali e difesa, un modo di allenare intenso e innovativo. Fresco. E i risultati arrivano. Alla guida delle V nere vince la Coppa Italia nel 1974 e lo scudetto nel 1976. Ricorda Adalberto Bortolotti:
“Quando arriva a Bologna lo scetticismo dilaga. I redattori che tornano dagli allenamenti mi confidano particolari agghiaccianti: non conosce la zona, confonde gli schemi, i giocatori sono frastornati”. Impressioni smentite dai fatti.
Nel 1978 l’Olimpia Milano, una grande storica del basket italiano, lo sceglie per rilanciarsi dopo anni difficili. Nessuno poteva saperlo, ma l’arrivo di coach Peterson avvia uno dei cicli migliori della storia della squadra milanese e del basket tricolore. Ormai ambientato, l’americano raffina il suo lavoro e crea una corazzata.
Riesce subito ad essere competitivo ai massimi livelli, ma per vincere serve l’innesto di un fuoriclasse. A una squadra già forte, costruita attorno a un playmaker chiamato Mike D’Antoni, nel 1981 viene aggiunto con un colpo di mercato Dino Meneghin.
Un rivale storico vista la lunga militanza a Varese, considerato ormai prossimo alla fine di una grande carriera. Soprattutto un centro dominante con già svariati titoli nel suo palmares, che porta mentalità vincente. Con quest’asse play-pivot Milano vola e i titoli fioccano.

Un tratto distintivo del suo lavoro a Milano è la zona 1-3-1. Un modulo innovativo rispetto a quelli classici, predicato su una forte aggressività in pressing. Per capire l’acume del personaggio va rilevato che Peterson per sua stessa ammissione non sapeva nulla della difesa a zona prima di venire in Italia.
Dal 1982 al 1987 l’Olimpia arriva sempre in finale scudetto vincendo quattro volte, insieme alla Coppa Korac nel 1985 e alla Coppa Italia nel 1986 e nel 1987. Ma è nell’ultima stagione a Milano che compie il suo capolavoro: a campionato e coppa aggiunge la Coppa dei Campioni ’87, completando un triplete storico.
Questo trionfo avviene grazie a un altro innesto fondamentale, quello di Bob Mc Adoo. Dopo 13 anni in NBA con, tra le altre cose, 2 titoli vinti, 18.787 punti segnati e un MVP nel 1975 l’americano firma per Milano. Una mossa totalmente ascrivibile a coach Peterson:
“McAdoo non è stato un’intuizione, c’è stato molto lavoro dietro. Ci ho messo 4 anni, per convincerlo! Quando arrivò non ero preoccupato di inserire una star del genere perché l’avevo già conosciuto. Se non il migliore giocatore mai venuto in Europa, ci manca poco”.
La base lasciata dall’allenatore porterà altri titoli, ma soprattutto lascerà il ricordo di un dominio raro. Arrivato grazie a un piccolo grande uomo dell’Illinois.