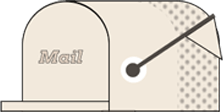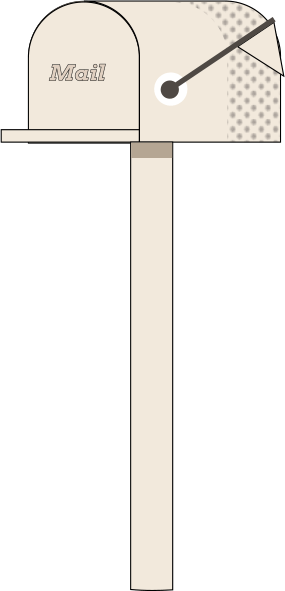Mentre Elvis Presley e Jimi Hendrix chiudevano le loro esistenze, Microsoft e Apple decidevano di conquistare il globo e l’Argentina vinceva il suo primo Mondiale, in Italia scorrevano piombo e sangue, la Mafia si scocciava della voce di Peppino Impastato e via Fani assisteva al rapimento di Aldo Moro.
Erano gli anni ‘70 e, con le stragi e le Brigate Rosse ad assaltare lo Stivale, il cinema western invecchiava in un sol colpo, lasciando che fosse un nuovo genere a impossessarsi delle sale.
Tra spaghetti e 44 Magnum, camuffando le maschere di Sergio Leone con il noir dei maestri americani e francesi, i registi del Bel Paese cominciavano infatti ad affollare di commissari le strade di Milano, Genova, Roma e Napoli; città incise da guerre livide e senza quartiere. Violenza, paura e spari campeggiavano sulle locandine: era nato il poliziesco all’italiana.
Fondato su un’epica giudicata da molti critici (non a torto) reazionaria e destrorsa, questo nuovo filone ha regalato almeno un decennio di pellicole spesso goffe e imperfette eppure maledettamente popolari.

Confinato dai contemporanei nella periferia del B-movie, il Poliziottesco è invece oggi accolto dal plauso di maestri come Quentin Tarantino, che ne ricordano con affetto oltre cento titoli capaci di cristallizzare un decennio tanto controverso quanto affascinante, regalando agli spettatori personaggi di assoluto culto.
“Se un giorno dovessi accorgermi di piacere moltissimo ai critici ma non più al pubblico, bè allora non proverei più gusto nel lavoro e smetterei”.
Occhi di ghiaccio e fisico da atleta, Maurizio Merli è stato forse il più celebre tra i volti del filone che ha consacrato Sergio Martino e Umberto Lenzi.
Scovato fra le pagine dei fotoromanzi ma con alle spalle persino qualche apparizione teatrale alla corte di Luca Ronconi, Merli incarnava il volto inflessibile di una Legge tanto ruvida nei modi quanto elegante nell’immagine.

Reso immortale da un paio di folti baffi lasciati crescere ― su consiglio del regista e produttore Marino Girolami ― per assomigliare il più possibile al divo Franco Nero, l’attore romano conquistava il pubblico per i suoi lineamenti a un tempo armoniosi e squadrati, oltre che per uno stile inappuntabile.
Trench beige o dolcevita nero, il protagonista di Roma a mano armata (1976) e Un poliziotto scomodo (1978) bucava lo schermo puntando criminali e fanciulle attraverso le lenti ambrate di un paio di Ray-Ban Aviator, mentre il polso destro si lasciava ammanettare da orologi con cinturini in pelle fine e massicci quadranti color oro.
Camicie blu o polo bianche appena sbottonate sul petto completavano poi il ritratto di un onestissimo mestierante, la cui pur non strabiliante espressività veniva bilanciata da un’efficace presenza scenica e dalla capacità di recitare anche le scene d’azione più complesse, senza dover ricorrere all’impiego di controfigure.
“L’Associazione Poliziotti Malpagati le augura la buonanotte!”
Lontano dalla patinata eleganza di Merli, quello di Mark Terzi e del suo interprete Franco Gasparri era al contrario un fascino più scanzonato e tenebroso. Sguardo tagliente e sorriso appena abbozzato, il volto di Gasparri si lasciava incorniciare da una barba appena incolta e da una selva di capelli scuri.
Mentre un fisico ben più esile e una naturale vena ironica facevano di lui un personaggio capace di alleggerire i toni violenti e quadrati del Poliziottesco coevo.

Milanese e beat, meno borghese e più sessantottino rispetto al collega biondo, Gasparri conobbe la celebrità grazie alla trilogia di Mark il poliziotto, diretta da Stelvio Massi, virtuoso della macchina da presa e direttore della fotografia dal talento nobile.
Massi riuscì così a tratteggiare sulla recitazione di Gasparri un nuovo modello di “uomo in divisa”, dilatando la brutalità delle pellicole coeve per stemperarla in un’originale lettura del genere.
Camicie bianche, a righe verticali o di jeans, pantaloni a zampa e giacca nera con il bavero alzato, nell’ultimo atto markiano ― Mark colpisce ancora (1976) ―, il commissario Terzi lascia il posto all’agente Mark Patti, completando la propria filmografia con un’interpretazione segnata da una virilità più sottile e meno fisica di quella di Merli, ma pur sempre efficace nell’afferrare il pubblico alla gola. Inseguimento dopo inseguimento.
“Avvertite il procuratore della Repubblica. Ditegli che l’ex commissario Grandi ha ucciso Giulio Sacchi”.
Non solo modelli da fotoromanzo però ― Gasparri, come Merli, proveniva “dalle edicole” ―, il Poliziottesco di fatti era nutrito soprattutto da caratteristi, brutti ceffi e femme fatale, a cominciare dal commissario Walter Grandi di Milano odia: la polizia non può sparare (1974) e dal cosmo malavitoso di Milano calibro 9 (1972).

Nato a New York e già adottato dall’universo western, sotto la regia di Lenzi il volto di Henry Silva squarciava le scene italiane puntando su un’estetica serpentina, opposta ai tratti piacenti dei protagonisti dei film citati in precedenza.
Strozzati da un maglione dolcevita che passava dall’amaranto al nero ― quasi a segnalare le tonalità regine di una stagione contraddistinta dal piombo e dal sangue ― i lineamenti impassibili di Silva riassumevano l’impotenza di una polizia che, pur di duellare alla pari con il crimine, si ritrovava costretta a superare persino i propri limiti morali.
Del cult firmato Ferdinando Di Leo, invece, restano impresse la selvaggia crudeltà di Ugo Pizza ― magistralmente interpretato da Gastone Moschin ― e lo sfrenato erotismo di Nelly Bordon ― una seducente Barbara Bouchet.
Se il primo, sigaretta in bocca e cranio rasato, paralizzava il cuore dello spettatore con uno sguardo folle, penetrante e assetato di vendetta, tutt’altri brividi scuotevano invece le movenze della go-go dancing della ragazza.

Nell’ormai celebre scena del Night Club, le curve di Barbara Bouchet, infatti frustavano tanto le fantasie degli uomini in sala quanto le perline di un bikini così succinto da lasciare ben poco spazio all’immaginazione.