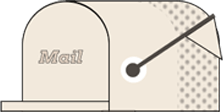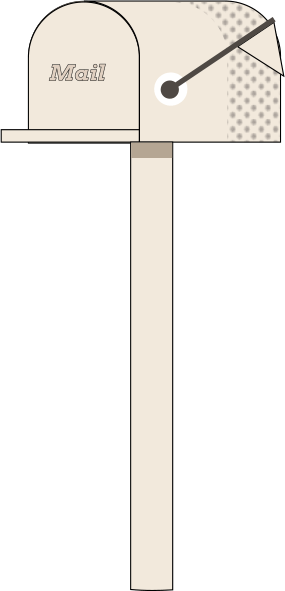Nel 1923, quando un giovane diplomato fu assunto alla Banca d’Italia, il cinema rischiò di perdere uno dei suoi nomi più brillanti. Il giovane Vittorio De Sica, che pure si è fatto la sua brava carriera da ragioniere, sente fortissimo il richiamo del palcoscenico: suo padre gli ha insegnato a cantare e lo ha accompagnato tante volte al pianoforte. Così, quando un amico gli dice che la compagnia di Tatiana Pavlova cerca attori, Vittorio chiede consiglio al padre. Se non fosse stato per il signor Umberto D., che credendo fermamente nel talento del figlio lo spinse a lasciare l’impiego sicuro in banca per tentar fortuna nel teatro, non avremmo avuto Vittorio De Sica.
«Sono nato a Sora, il 7 luglio 1901, dunque sono ciociaro, anzi cafone.»
In realtà De Sica non era né l’una né l’altra cosa: il portamento distinto, i modi impeccabili, era una galantuomo nato fuori e dentro lo schermo. E nonostante la carta d’identità, si sentì sempre napoletano, la città dove aveva passato gli anni dell’infanzia.
Con 31 regie e più di 140 ruoli da attore, Vittorio De Sica è uno dei più prolifici esponenti del cinema italiano, in grado di spaziare dalla commedia rosa al neorealismo, da film nazional popolari come “Pane, amore e fantasia” al malinconico “Umberto D.”, sulla solitudine di un pensionato a cui la vita non ha più nulla da offrire. Recitare, per lui, era naturale come respirare, sia in teatro che sul set:
«Io ho guadagnato fama e quattrini lasciandomi guidare dalla pigrizia.»
Nel 1932 il pubblico si innamorò di lui in “Gli uomini, che mascalzoni”. Vittorio interpretava un giovanotto in bicicletta che rincorre una bella ragazza sul tram. La sigaretta all’angolo delle labbra, la giacca con un solo bottone e il cappello sulle ventitré: la scena in cui balla cantando «Parlami d’amore Mariù» – che De Sica detestava cordialmente – è diventata così iconica da superare la fama del film.
Smilzo, sorridente e imbrillantinato, era il perfetto protagonista delle commedie dei telefoni bianchi. Ma vuole uscire dal ruolo del seduttore in frack e passare dall’altra parte della macchina da presa. Nel 1946 gira “Sciuscià”, con cui riceve il primo Oscar: sullo schermo non ci sono più salotti borghesi e signore impellicciate, ma le macerie del dopoguerra, i poveracci che ogni giorno si inventano la vita. È il neorealismo, corrente di cui sarà uno dei più grandi interpreti. Per girare “Ladri di biciclette” chiede aiuto ai produttori hollywoodiani, che accettano a condizione che il protagonista sia Cary Grant. Vittorio De Sica ringrazia e rifiuta: a costo di rimetterci di tasca sua, come protagonista vuole assolutamente un garagista romano che non ha mai recitato in vita sua.

Nonostante i riconoscimenti – quattro Oscar, la Palma d’Oro e quattro David di Donatello – il botteghino non sempre lo premia. Per necessità e per vocazione, continua a recitare. Nel 1953 inizia la saga di “Pane, amore e fantasia”: De Sica è così amato nel ruolo del maggiore Carotenuto che la gente per strada lo chiama marescia’. Indimenticabile il mambo con Sophia Loren, attrice di cui era amico, mentore e pigmalione: lui le fece vincere un Oscar per “La ciociara”.
Al cinema regala una galleria di personaggi specchio dell’Italia d’allora: il nobile decaduto, l’avvocato azzeccagarbugli, gli onorevolissimi mascalzoni. La sua comicità nasce dal contrasto tra l’aspetto aristocratico – alto, distinto, i capelli d’argento e i baffi curati– e i personaggi “gigioni” che interpreta, cialtroni dall’animo nobile, sempre pronti a inventarsene una. Come lo spiantato Conte Max che in cappotto lungo, guanti e fiore all’occhiello insegna l’etichetta al giovane Alberto Sordi, sperando di scroccargli qualche risparmio.

Anche fuori dal set De Sica aveva le sue debolezze. Due, su tutte: le donne e il gioco d’azzardo.
«Ecco il segreto del vero signore – rivela De Sica a Sordi – stare al tavolo da gioco come se non rischiasse nulla.»
Al casinò era altrettanto signorile: baciava le mani delle signore e lasciava la mancia ai croupier anche quando si era giocato tutto, perfino le paghe dei suoi attori. Eugenio Scalfari lo conobbe da ragazzo, perché suo padre dirigeva il Casinò di Sanremo, di cui De Sica era un assiduo frequentatore. Il giornalista lo ricorda mentre suonava al pianoforte di casa sua:
«Era molto elegante e mi colpì il fatto che portasse le ghette bianche. Un giorno mio padre raccontò che avevano dato il viatico a De Sica, un contributo per i clienti affezionati che non avevano più neanche i soldi per il biglietto del treno.»
Padre amorevole di due famiglie – una con Giuditta Rissone, madre di Emilia, l’altra con Maria Mercader, madre di Manuel e dell’attore Christian – se ne andò nel 1974 dopo aver lasciato al cinema italiano capolavori come “Matrimonio all’italiana” e “Il giardino dei Finzi-Contini”. L’ultimo film che volle vedere, prima di morire, fu Ben Hur.