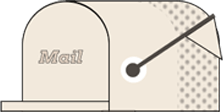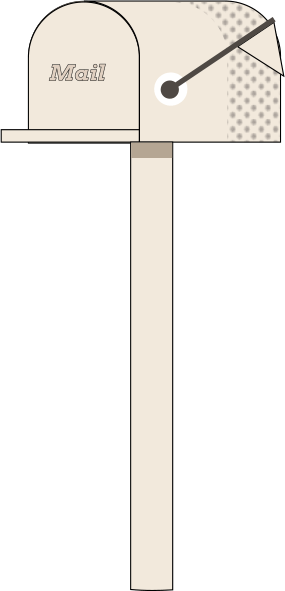Nel corso degli anni, anche i più recenti, il regista Francesco Rosi ha parlato spesso di Luchino Visconti, sontuoso caposaldo del nostro cinema di cui l’autore di ‘Salvatore Giuliano’ fu allievo devoto e aiuto regista. Una testimonianza carica di affettuosità, ma permeata da una certa dose di umorismo nero e da quella vena insurrezionale propria di ogni grande scolaro, che restituisce come meglio non si potrebbe l’idea di eleganza di Visconti.
“Aveva questo berretto di lana dell’esercito americano che non toglieva mai. Anche quando c’è stato il periodo dell’odio furibondo, perché aveva trattato male me, Franco Zeffirelli e tutti quanti, tanto che per un mese non ci ha mai parlato, quel cappelletto se lo teneva sempre in testa e a me dava un po’ fastidio. Pensavo: ci odia, ma intanto si tiene il cappello. Una volta però è sceso, col cappello, da una piazza scivolosa ed è cascato. Io e Franco Zeffirelli, quando abbiamo visto cadere anche lui, ci siamo detti: anche i boia muoiono”.
Un uomo e un artista che ha vissuto il culto della forma con un’aderenza senza pari tanto alla realtà ― quella del neorealismo, della prosaicità, del quotidiano, di Ossessione ― quanto alla propria vocazione barocca e decadente. Il formalismo di Visconti e il suo estetismo non erano solo un’esibizione di eleganza e di stile, ma la sua idea di mondo, lampante e inequivocabile.
Il “Conte rosso”, come Visconti fu soprannominato, visse un’esistenza carica di contrasti ― il suo populismo, come lo si definirebbe oggi, non fu mai privo di una vena aristocratica ― ma seppe sempre sublimarli attraverso varie forme espressive. Nel 1938, Luchino Visconti si racconta così:
“Mi hanno spesso accusato di una ricerca esagerata del dettaglio della scenografia, dell’arredamento, dei costumi. Mi sembra un’accusa falsa perché la ricerca non è mai eccessiva”.
Il realismo magico francese, dal quale la sua carriera è partita, la grande tradizione operistica di Senso, la portata del romanzo ottocentesco con cui fare i conti ne ‘Il gattopardo’), il decadentismo estremo e disperato degli ultimi film come ‘La caduta degli dei’ e ‘Ludwig’, il suo perfezionismo maniacale.

Anche se sapeva che non sarebbero mai stati inquadrati, Visconti pretese che i fazzoletti e la biancheria riposti nei cassetti degli ambienti de ‘Il gattopardo’ fossero filologicamente in linea con l’epoca nella quale il film era ambientato: un dettaglio leggendario e più volte enfatizzato, che restituisce però benissimo la tempra di una classe che non scendeva mai a compromessi.
“Elegante com’era, nel pensare, nel vivere, oltreché nel lavorare, penso che Luchino mettesse la cattiveria, più che la bontà, nel novero delle cose eleganti: era elegante, per lui, la negatività nel suo duplice aspetto di sadismo, e masochismo”.
Sono parole di Claudia Cardinale, sua musa prediletta ― insieme agli attori Alain Delon e, in misura anche maggiore, Helmut Berger ― che seppe radiografare in maniera intima e sfaccettata il suo Luchino, padre putativo, il mentore, il maestro e amico di una vita.
La Cardinale di Visconti colse la sua ambivalenza, il mistero, la compresenza di luci e ombre esposte e contrapposte in maniera sfacciata e privatissima. Da un lato, lo sfarzo esemplare, sul quale l’attrice di origini siciliane si è più volte soffermata:
“Ha insegnato a tutti i suoi colleghi, per esempio, come deve vestirsi un regista sul set, per essere comodo, e insieme, visibilmente ‘speciale’. Credo di non aver mai visto un uomo vestito con tale eleganza. Tutto in lui era di una classe superlativa”.
Dall’altro, però, la “cattiveria”, che ritorna nelle parole della Cardinale, per sottolineare un altro elemento del carattere di Visconti, ovvero l’assenza di gentilezza come unico parametro per scolpire nella pietra rapporti formali attraverso cui interloquire con i propri attori o sottoposti.
“Visconti era generoso, sensibile, educato, tenero, ma mai gentile. Tutto, in lui, era valutato in base al criterio dell’eleganza. La gentilezza non era elegante. A suo parere, solo la cattiveria lo era. Poteva divertirsi con chiunque come fa il gatto con il topo”.
I criteri con cui Visconti si rapportava con il mondo e con le persone, non avevano nulla di democratico, scrutava e squadrava chi gli stava accanto e i fenomeni che gli si muovevano attorno.

Non stupisce, dunque, che la sensibilità del regista sia approdata nei suoi ultimi anni di vita e di carriera verso esiti apocalittici, nei quali l’utilizzo di un apparato visivo sontuoso e sublime si dovesse tingere costantemente di morte, in maniera quasi programmatica.
Una prova emblematica di ciò è la fine del mondo colto e aristocratico incarnato da Aschenbach ― modellato su Gustav Mahler ― in ‘Morte a Venezia’: un esteta ossessionato dagli ideali di bellezza e dalla bellezza ideale, dal moralismo della forma, dall’astrazione dei sensi, in un film che fa i conti in modo diretto e struggente con l’omosessualità mai pacificata e sempre lacerante del regista milanese.
Visconti, proprio in virtù della sua eleganza fuori dal tempo e al contempo assolutamente dentro il suo tempo, fu e rimane un autore ideologicamente problematico.
Non troppo di moda, purtroppo, nelle gerarchie sia del chiacchiericcio popolare che degli studi accademici contemporanei, ma capace di toccare la nuda pelle di contrasti ancora scottanti e non sanati, come il gender, lo scorrere del tempo, l’accettazione dei propri fallimenti e delle meschinità più intime che appartengono a tutti noi.