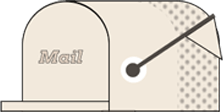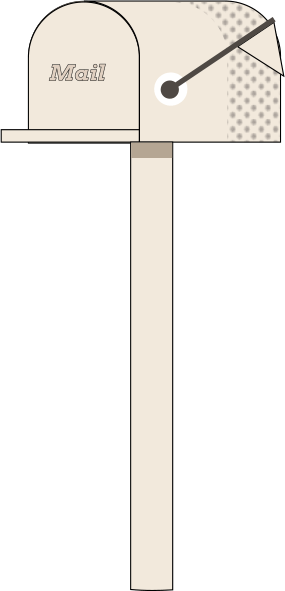Con un litigio di carta e inchiostro. Così la Divina rinuncia al suo Vate, mentre la piazza arde per le gravi parole di Lui e la sala palpita per i bei gesti di Lei. È l’estate del 1922 all’Hotel Cavour di Milano e a separare i due amanti non restano che un paio di stanze, un groviglio di corridoi e quei diciassette anni dal loro ultimo addio.
“Gli perdono di avermi sfruttata, rovinata, umiliata.
Gli perdono tutto, perché ho amato”.
Nata a Vigevano nel 1858 da una modesta famiglia di attori, Eleonora Duse comincia a recitare sin da giovanissima, conquistando i teatri di tutto il mondo per la modernità delle sue pose.
Lontana dall’affettata drammaturgia ottocentesca, infatti, la Duse si sottrae agli slanci enfatici delle colleghe, raccogliendosi nelle minute nevrosi di una voce sottile, sfumando le parole con pause e silenzi, perdendosi nella vertigine di uno sguardo.
Eleonora restituisce un’immediata impressione di realismo e, rifuggendo la sintassi scenica del tempo, incide l’ossessione dei suoi personaggi su di uno stipite prima di abbandonare le proprie eroine alla gelida seduta di una poltrona.
“È molto più che bella. D’un pallore opaco e un po’ olivastro, la fronte solida sotto le ciocche nere, le sopracciglia serpentine, i begli occhi dallo sguardo clemente”.
Ricca e indipendente, irrequieta e tutt’altro che fragile, la Duse alimenta la propria aura divistica concedendosi di rado all’avidità dei giornalisti, a cui preferisce la compagnia di artisti e intellettuali; curioso, dunque, come a insidiare quelle dolci forme ormai all’apice del proprio successo giunga, nel 1882, un “lupetto d’Abruzzo” diviso tra divertissement mondani e decadentismo lirico.
Di cinque anni più giovane, non molto alto ma piacente, dandy nei vezzi e nei modi, Gabriele D’Annunzio, infatti, è un brillante seduttore già avviato verso l’immortalità dell’alloro e deciso a conquistare le grazie della celebre Eleonora che, almeno inizialmente, si nega però al Poeta.
“Preferirei morire in un cantone piuttosto che amare un’anima tale. D’Annunzio lo detesto, ma lo adoro”.
Dopo il diniego delle prime, sfrontate carezze amorose dell’Immaginifico, tuttavia, nel 1895 il cuore della Diva capitola e le anime dei due cominciano a danzare.
D’Annunzio la ritrae come una Musa paragonandola, anzi, al Teatro stesso; l’attrice, a sua volta, è ammaliata dai delicati furori di una prosa che sembra crepitare e incendiarsi a ogni lettura quando, annoiata dalla prevedibilità di un repertorio ormai stantio, chiede al poeta di scrivere per lei.

Sono anni di lavoro febbrile e di morboso abbandono nel nido di Settignano, vicino Firenze; qui, Gabriele affitta una sfarzosa villa, la Capponcina, non molto lontana dalla “francescana” Porziuncola dove, invece, alloggia Eleonora.
Una fitta corrispondenza trascina questa travolgente passione fra le pagine delle missive in cui Lei, che talvolta lo chiama persino “figlio”, incontra i dolci vezzeggiativi di Lui, assolvendolo dai continui tradimenti che il giovane le riserva.
“Non parlarmi dell’impero della ragione, della tua vita carnale, della tua sete di vita gioiosa. Sono sazia di queste parole!”
Da anni l’autore la considera, infatti, un misero grimaldello cui affidare il proprio genio (e il proprio mito) per librarsi sulle scene, offrendo la sua prima tragedia ― La città morta, composta in origine per la Duse ― alla celebre Sara Bernhardt, rivale artistica di Eleonora, e rinfacciando all’amata il fallimento de Il sogno d’un mattino di primavera, opera etichettata dalla critica come “presuntuosa e di una noia insopportabile”.
Agli adulteri professionali si aggiungono poi quelli sentimentali, con le liaison di Gabriele che non si contano e con le lacrime dell’attrice che pur non lo rinnegano; preda dell’amore per il Vate, infatti, la Divina sopporta tutto, persino la vile rappresentazione che D’Annunzio propone di lei nel romanzo Il Fuoco, tra le cui pagine prende vita il profilo lascivo di Foscarina e la cinica descrizione della sua grazia ormai sfiorita.
“Io sento tutte le forze che straripano in te ma non so andare a nuoto con te per l’acqua fonda. Sei tu il più forte”.
È l’estate del 1922 all’Hotel Cavour di Milano e a separare i due amanti non restano che quei diciassette anni dal loro ultimo addio. Ma ormai è tardi. Eleonora ha già rinunciato a Gabriele nel 1904, sconvolta dal cinismo con cui Lui, approfittando di un malore di Lei, affida alla giovane e avvenente Irma Grammatica le fortune della sua ultima fatica, La figlia di Iorio.
Sola e straziata, la Duse ripudia il Teatro, salvo poi ritornarvi e incantare il suo pubblico con Gli spettri di Ibsen, mentre D’Annunzio conquista donne e cieli prima di rinchiudersi in un amaro congedo.
Eleonora Duse muore a Pittsburgh il 21 aprile 1924 durante una tournée, lontana dagli ultimi affetti e dai luoghi a lei cari. Qualche miglio più a Est, nella dimora del Vittoriale, Gabriele D’Annunzio passa in rassegna i cimeli del proprio studiolo: i globi antichi, le stampe sistine, i volumi rilegati in marocchino.
E si arresta, infine, davanti a un busto velato, che libera dal foulard scoprendone il volto. Un ultimo sguardo del Vate alla sua Divina.
“È morta quella che non meritai”.