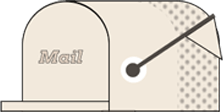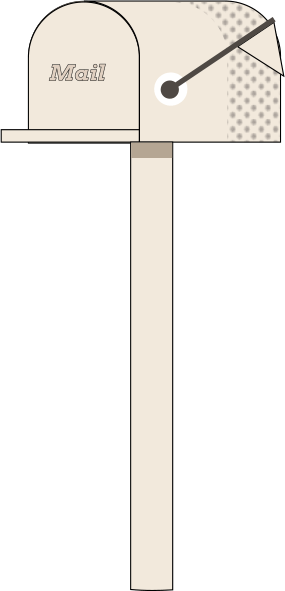Avrebbe compiuto 80 anni questo 18 febbraio il nostro amato Fabrizio De Andrè, il musicista che ha segnato come nessun altro la cultura italiana del secolo passato. Qui, lo ricordiamo attraverso i suoi versi.
Io t’ho amato sempre, non t’ho amato mai; amore che vieni, amore che vai.
Pubblicata nel 1966 come lato B del singolo Geordie, Amore che vieni, amore che vai è uno dei brani più suonati di De Andrè: è un pezzo che parla di tutti gli amori, destinati a passare, così come passano le stagioni. È una canzone essenziale, semplice, universale, che ben delinea la poetica di De Andrè, su più temi ricorrenti dei suoi testi: l’amore, il tempo, la fine.

Ma perché lo ricordiamo con il soprannome di Faber? Questo è molto più di un semplice diminutivo del nome Fabrizio e rivela un retroscena sulla vita privata dell’artista. Si potrebbe pensare che sia un riferimento latino a “colui che fa, colui che crea” in quanto poeta, eppure questo soprannome gli fu dato da Paolo Villaggio, conterraneo e grande amico del cantautore genovese, e si riferisce ai Faber-Castell, i pastelli colorati di cui De Andrè era un grande utilizzatore e amante.

Villaggio, prima di scomparire nel 2017, ha spesso parlato della loro amicizia, profonda e stretta, nata in montagna, a Cortina, nel 1948: Villaggio era “un ragazzino incazzato che parlava sporco”, diceva De Andrè, “Gli piacevo perché ero tormentato, inquieto ed egli lo era altrettanto, solo che era più controllato”. Erano due ribelli, nati in due famiglie bene della Genova degli anni ‘40. Insieme scrissero Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers, edita come singolo nel ’63, ma che uscì in Volume 1, il primo album di inediti del cantautore che lo consacra definitivamente al grande pubblico.
Lo stesso album si apre con Preghiera in gennaio, dedicata all’amico Tenco, ritrovato senza vita nella propria stanza d’albergo a Sanremo nel 1967 durante il Festival. È una preghiera laica, di misericordia, più una poesia che una canzone, con cui De Andrè, affrontando il tema della religione e della morte, chiede che il suo amico venga accolto in Paradiso insieme a tutti i suicidi:
Signori benpensanti spero non vi dispiaccia se in cielo, in mezzo ai Santi
Dio, fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte
che all’odio e all’ignoranza preferirono la morte.
Genova, la città che ha dato i natali al cantautore è presente nelle sue canzoni e protagonista di molte scene di vita: si pensi a Città vecchia, con il racconto nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ma anche a Via del Campo teatro di vita vera vissuta da De Andrè giorno e notte, e che si conclude con il verso: dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior.
«Genova per me è come una madre. È dove ho imparato a vivere: oggi a me pare che Genova abbia la faccia di tutti i poveri diavoli che ho conosciuto nei suo carruggi, gli esclusi che avrei poi ritrovato in Sardegna, le “graziose” di via del Campo.
Come non menzionare poi il quartiere di Sant’Ilario, dove oggi si può si ammirare un panorama incredibile sul mare, senza dimenticare l’intramontabile pezzo di Bocca di Rosa: la stazione ferroviaria da cui la protagonista parte è ormai in disuso perché soppressa, ma il quartiere mantiene il ricordo imperituro e in una teca è riposta una scultura a libro contenente l’acrostico di Bocca di Rosa.
Nella pietà che non cede al rancore,
madre, ho imparato l’amore.
1970. Nei mesi più fervidi della contestazione, De Andrè esce con un album apparentemente controrivoluzionario, dando vita a una reinterpretazione allegorica dei Vangeli Apocrifi, con cui mette in scena la versione più umana di Gesù e dei personaggi secondari che popolano le sacre scritture. Emblematico il testo de Il testamento di Tito, il pezzo che, attraverso il punto di vista del ladrone, ripercorre la sua vita di peccatore elencando i Dieci Comandamenti. Ogni uomo è Tito: attraverso la sua figura De Andrè elenca l’eticità degli imperativi più sacri, attaccando l’ipocrisia dei finti benpensanti che pretendono ad ogni occasione di far finire sulla croce qualcuno per non aver rispettato un comandamento.
Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore:
«Tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?»
Il brano La collina apre il terzo concept album dell’artista genovese, basato sull’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, tradotto in italiano da Fernanda Pivano, poetessa e amica di De Andrè. In questa sorta di canzone-prologo, il cantautore si chiede dove siano Elmer, Bert e Tom uccisi chi in una rissa, e poi Maggie, che in un bordello ha tirato il suo ultimo respiro.
La risposta è univoca, nel ritornello: “Dormono tutti sulla collina”, che ospita uno dei cimiteri più celebri cantati. L’opera poi racconta degli abitanti più o meno freak che hanno vissuto nel paese di Spoon River e che ora giacciono sepolti: prendendo ad ispirazione gli epitaffi della letteratura originale arrivano Un matto, alias Frank Drummer, un personaggio ritenuto pazzo ed internato in un manicomio perché non riusciva a comunicare i suoi pensieri attraverso il linguaggio, e Un giudice, al secolo, Selah Lively, spesso per la sua bassa statura, ma che diventando giudice si vendica, incutendo timore a coloro che prima lo irridevano.
Ma c’è amore un po’ per tutti
e tutti quanti hanno un amore
sulla cattiva strada
Metà degli anni ’70, De Andrè si trasferisce in Sardegna e in Cattiva strada parla la più “americana” delle sue anime. Una ballata scritta con Francesco De Gregori nella sua casa in Gallura, tra sigarette e bicchierini appena svegli.
È un viaggio armonioso ma anche ossessivo che racconta il percorso di un uomo verso il rifiuto di ciò che è giusto solo perché imposto. Un altro “emarginato” con cui De Andrè empatizza, perché come lui fa scelte non semplici o “sbagliate”. Ma dove è il giusto e dove lo sbaglio quando si mette in discussione se stessi e il proprio cammino, deviando dal tracciato stabilito e assumendosene ogni conseguenza? È forse una delle domande esistenziali che più attanagliano l’autore nei 6 lunghi mesi del rapimento nelle campagne sarde del ’79.
Ombre di facce, facce di marinai, | da dove venite, dov’è che andate?».
«Umbre de muri, muri de mainé, | dunde ne vegni, duve l’è ch’ané?».
Creuza de mä, l’album, nato dalla collaborazione artistica tra De André e Mauro Pagani e pubblicato nel 1984, è il punto d’arrivo di una carriera illustre e frutto di un’operazione di archeologia musicale e linguistica senza pari. Scritto in dialetto genovese e suonato con strumenti della tradizione mediterranea e nordafricana, Creuza de mä è un disco sul mare, sul viaggio senza fine di chi lo attraversa, sulle storie piccole e grandi che puntellano ogni approdo in un porto. È difficile scegliere un brano piuttosto che un altro in rappresentanza della raccolta e per questo la title track appare la più azzeccata perché racconta una storia di marinai, di “emigranti della risata con i chiodi negli occhi”.
Il tredicesimo ed ultimo album di De Andrè, targato 1996, è frutto di un lavoro a quattro mani con il collega e concittadino Ivano Fossati. In Anime salve il tema prevalente della raccolta è la solitudine, in tutte le sue forme e raccontata attraverso i protagonisti delle canzoni: quella della transessuale, del Rom, dell’amante, del pescatore e anche quella scelta dallo stesso artista, come condizione ideale.
Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria
col suo marchio speciale di speciale disperazione
e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi
per consegnare alla morte una goccia di splendore di umanità di verità.
Lo stesso titolo dell’album significa “spiriti solitari”, tanto che l’intero disco può essere considerato un “elogio della solitudine”, che permette di essere liberi e non condizionati dalla società. L’ultimo pezzo della raccolta è Smisurata preghiera che racconta le considerazioni sui temi fondamentali della vita di un marinaio errante: considerata l’epitome dell’intero disco e dei suoi temi, è una sorta di richiesta, da parte di quegli uomini che per la libertà hanno scelto la solitudine, di un riscatto, per quanto impossibile, smisuratamente necessario. Si può dire che il brano è il sunto dell’intera opera di Fabrizio De André, il suo messaggio definitivo; è un atto d’amore per tutte le minoranze, un testamento senza tempo, più che mai attuale.